Architetto
| Pubblicato su: | Il nuovo Corriere della Sera, anno LXXXIII, fasc. 17, p. 3 | ||
| Data: | 19 gennaio 1958 |
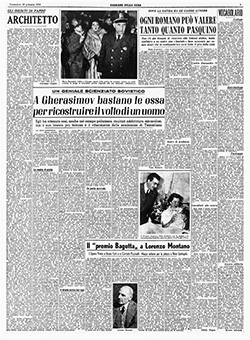
pag. 3
Certi Platoacini in dodicimillesimo grandificano l'architetto perchè esente, al par del musico, dall'imitazione delle cose naturali. Ma è scimmia anche lui, come tutti, almeno al principio, e non ha deformato tanto i suoi modelli da farne perdere la memoria. Nè ha copiato la natura soltanto.
L'idea della volta vien dalle grotte; quella del tetto colle travi parallele e pendenti dallo scheletro del torace. La colonna è ispirata dalle stalattiti delle caverne o dai tronchi degli alberi e il pilastro non è che una colonna squadrata e la torre una colonna vuotata. L'obelisco è il phallus geometrizzato: la piramide una collina stilizzata; l'anfiteatro un cratere vulcanico ridotto a gradinate; la cupola la volta celeste chiusa e rimpicciolita. Lungo i fiumi i primi uomini trovarono i ponti naturali creati dall'erosione dell'acque e dagli abitacoli conici dei castori tolsero l'idea della capanna di rami.
Il tempio greco è l'ingrandimento d'un cofano o d'una tomba; le cattedrali gotiche son montagne irte di picchi (guglie) che portan nel ventre una selva, oppure somigliano a favolose navi di pietra arenate sulle pianure e destinate, come l'Arca, a raccogliere i salvandi dal gran diluvio della barbarie. E tutta la parte ornativa degli edifizi, cominciando dal capitello. è un abile saccheggio della flora e della fauna. L'indipendenza creativa dell'architetto è una delle tante immaginazioni del nostro orgoglio.
Ma nel trascorrer dei secoli il demone geometrico e più di tutto la destinazione pratica degli edifici fecero deformare e mascherare quelle originarie copiature. Però, se l'architetto si avvantaggia sopra gli altri maestri d'arte per aver raggiunto una maggior libertà rispetto al reale ha pagato questo privilegio con una persistente schiavitù ai bisogni dei suoi clienti. Le altre arti si sono affrancate via via dalle loro origini utilitarie. La pittura non è più linguaggio figurato, geroglifico: la statuaria non e più soltanto conservatrice dell'aspetto dei morti. la musica ha perduto i suoi uffici magici primitivi; la poesia non serve più a fissare in formule ricordative precetti o memorie. L'architettura invece no: come al principio è soggetta alle necessità della vita comune: il palazzo più meraviglioso è fatto per dormire e mangiare; la chiesa per accogliere i prostrati intorno a Dio; il teatro per contenere gente seduta: tutta la fantasia del costruttore deve tener conto di questi scopi. C'è una poesia pura — ma non può esserci architettura pura.
Anch'essa, come tutte l'arti, ha per fine la redenzione della materia; deve render leggera la pesantezza, spirituale la solidità e far vivere le pietre, i marmi, i mattoni: dare un'anima all'inanimato. E qui la difficoltà è maggiore assai che nella pittura o nella poesia dove la parte della materia — veli di colore, suoni — è piccola in confronto allo spirito che la impronta e la solleva. L'architetto, per ottenere cogli accordi delle masse e l'armonia delle proporzioni e gli spartimenti d'ombre e luce la vittoria sulla massa ingente di materia che adopra dève avere in se una potenza sublimatrice assai maggiore di quella che occorre al musico, che adoprava, può dirsi, materia quasi immateriale.
E nonostante i grandi architetti son riusciti a far esprimere, agli edilizi, i medesimi sentimenti che illuminano un quadro o una lirica. D'un mucchio di sassi e di calce hanno fatto, col genio, una gran faccia parlante. Una bella fabbrica dipinge colui che l'abita o ispira le passioni per le quali fu inalzata. E' un ritratto e un linguaggio. Come certe musiche eccitano al coraggio e altre alla voluttà gli edifizi perfetti dirigono e suggeriscono gli animi degli uomini. Il tempio, colla sua grandezza, parla della maestà del Dio che l'aita e col mistero del suo interno — simile a quello d'una tomba — piega all'umiltà. Il Palazzo Regio colla sua vasta ricchezza forza all'ammirazione e alla riverenza dei monarchi. Il Castello, fatto per difesa, coi suoi blocchi e i suoi torrioni incute timore: il Palazzo signorile, colla sua facciata fastosa, dà l'idea della gioia ma suscita insieme l'invidia. Le cattedrali del medioevo, colla moltitudine delle loro statue, dei bassorilievi, degli ornamenti, dei simboli erano grandi libri sacri e allegorici per l'edificazione delle plebi: un portale era un sermone, talvolta il compendio d'una somma o d'un poema.
Ogni vera chiesa è come un immenso ventre materno tiepido e amoroso dove gli uomini ritrovano un po' della loro innocenza; dove si sentono più prossimi alla Madre carnale d'Iddio, e per suo mezzo al Figlio e al Padre. Chiusa dietro di noi la porta ci sentiamo come divisi dal mondo: basta un muro a separar l'anima insudiciata dalle miserie quotidiane: le colonne son abeti d'un bosco, i lumi stelle d'un firmamento più alla mano e attraverso i colori ardenti delle vetrate anche il cielo più ceneroso di gennaio sembra quello d'una primavera orientale. E se la torre profana che quasi sempre ricorda Babele significa voler esser sopra a tutti, lontani dai fratelli e cioè orgogliosi, il campanile, colla sua guglia, è un voler avvicinarsi al cielo, a Dio: significa nostalgia dell'ultima ascensione, volontà d'amore. Oggi non più torri nè campanili: ma stie di ferro e di vetro soprammesse l'una all'altra quante più ne stanno, coll'intenzione proclamata di grattare il cielo: il cielo non si desidera più ma si vuole, con grossolana ironia, fargli il solletico.
La casa, dicono gl'ingegneri che stanno sbrattando gli ultimi architetti, è una macchina per abitare. La sua bellezza consiste nella chiara enunciazione del suo ufficio, nella meccanica e matematica nudità. E certe officine, certe stazioni, certe rimesse gigantesche d'acroplani hanno una loro sincerità solenne, che può incantare gli occhi dei piloti, dei lottatori e degli scolari dei politecnici. Gli architetti, dopo aver copiato la natura, si danno ora a copiare l'opere del passato, rammestando bestialmente tutti gli stili per i gusti bestiali degli arricchiti e dei governi.
La grande architettura nasce da una fede innamorata, da un istinto di adorazione, da un matrimonio tra l'anima e la natura. Oggi, agli uomini deificati, non piacciono profondamente che le forme e le utilità della materia all'ingrosso: non più reggia ma hôtels: non più cattedrali ma hangars; non più castelli ma silos; non più palazzi ma impalcature scientifiche d'acciaio e di cemento. Lo spirito non doma più la materia ma la serve epperciò non può animarla e imprimerle bellezze. All'arte divina, allieva dell'architettore demiurgo, è ormai succeduta la jattanza matematica dell'edilizia ingegneresca che ha per motto: Grattate il cielo e avrete il regno della terra.
◄ Indice 1958
◄ Corriere della Sera
◄ Cronologia